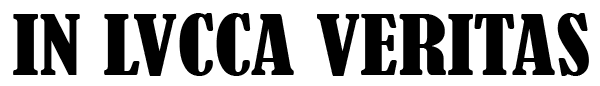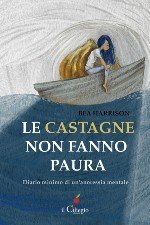Mi permetto di segnalare ai lettori il libro di Bea Harrison, autrice anglosassone, mai sentita nominare prima d'ora. Si tratta di una storia vera. La Harrison scrive bene, ma non è questo il motivo per cui la vicenda arriva dritta al cuore: c'è qualcosa di più del semplice scrivere bene, ed è, ovviamente, il fatto che la storia è stata vissuta in prima persona. Faccio un esempio: il colpo di scena (io così l'ho vissuto, ma per questo non voglio in alcun modo sdrammatizzare l'episodio né derubricarlo a mero artificio letterario) di quando la madre si rende conto che la figlia va in bagno a vomitare subito dopo aver cenato, sortisce esattamente l'effetto che si propone. Trasmette perfettamente al lettore la sorpresa, lo sbalordimento, della madre-autrice. Pur consapevole della "tempesta", non aveva nemmeno preso in considerazione che lo potesse fare.
Il lettore è già stato introdotto alla tematica, sa che è una storia di anoressia, esattamente come ormai ne è consapevole la madre. Tuttavia entrambe rimangono di sasso. La sensazione dall'Autrice al lettore passa magistralmente, l'immedesimazione è totale. Si parla di "tempesta". Ogni adolescente è una tempesta in quanto tale. Ma qui la tempesta è la malattia. La metafora è ottima, la si vede arrivare un po' alla volta, poi sempre più forte. La cosa che inquieta, anche qui, è che si tratta di gente consapevole, che sa il fatto proprio, non una famiglia sbandata o un'adolescente difficile. E nondimeno la tempesta li travolge. È successo a loro, può succedere a chiunque.
La storia è angosciante, è a tratti incredibile. Intanto, mi verrebbe quasi da dire, le malate sono due: B., ma anche la sua mamma. Quando una persona è malata, lo è tutta la famiglia, lo sono tutte le persone che le vogliono bene. La mamma è "malata" quanto la figlia non nel senso che anche lei si nutre unicamente a base di semini, ma in virtù del fatto che è consapevole della malattia, che ha ricadute (pesanti) anche su di lei, sia a livello psicologico che a livello pratico, organizzativo, di vita familiare. Quindi ci sono due persone intrappolate nella malattia, ma c'è un altro aspetto ancora più inquietante, davvero sorprendente: sono sole.
Se avessi conosciuto personalmente le persone coinvolte nella vicenda, per quanto simpatetico, avrei in realtà sottovalutato la loro esperienza, forse anche perché alla fine si è risolto tutto. Ok, c'è stato un problema di anoressia, anche piuttosto grave, ma B. sarà stata sicuramente seguita da professionisti medici, da una struttura del servizio sanitario, pubblica o privata. Invece, no. Niente di tutto questo. (Nota: non si dice qual è l'ospedale della città nel cui reparto di neuro-psichiatria infantile B. viene portata. Io ho avuto esperienza di quello di Lucca e non è stata una bella esperienza).
Le due sono sole, l'Autrice utilizza l'analogia della giostra impazzita, ma la giostra dà idea di spazio aperto, mentre questo è un mondo chiuso. Dove il resto della famiglia non riesce a essere coinvolto, gli amici, la scuola... Meno che meno i medici, appunto.
Quindi comincia una cura fai da te. L'Autrice lo ammette candidamente, si è dovuta arrangiare, improvvisare. In questo senso, un episodio che può sembrare secondario, come quello del "gioco delle parole", non lo è affatto. La mamma si rimette a leggere il curriculum di uno psicologo con cui si era tentato un approccio. Trova scritto nella titolatura e tra le competenze specialistiche qualcosa di "linguistico" che, per puro caso, è anche il mestiere della mamma. E ci lavora sopra. L'impressione è quella che si è davvero dovuto raschiare il fondo del barile. Lo si è fatto, però, con creatività, il sostrato culturale di ognuno di noi fa la differenza.
Ci sono tanti altri aspetti interessanti, molto affascinante è il "rituale religioso" (l'analogia è efficace) con cui madre e figlia cucinano cose speciali dopo aver fatto spesa in appositi negozi. Ovviamente non ho nessun tipo di competenza, metto lì due cose senza nessuna pretesa.
Primo: nel caso "opposto" all'anoressia, le persone molto obese, l'obeso ha sempre un complice, lui (o lei) non cucinano mai. Il medico coinvolge sempre il "colluso", il cuoco, all'interno della terapia. Anche qui c'è il complice (se conoscessi la Harrison mi scuserei per la metafora così rozza, ma è giusto per capirci), che, però, ha chiaro (o spera di aver chiaro) che deve tenere sotto controllo la situazione, non si deve andare a rottura con B., ma al tempo stesso la cosa non deve sfuggire di mano. E sta quasi sfuggendo. Siamo sulla lama di un rasoio.
Secondo aspetto: la madre viene "rimproverata" di tanta collusione con gli interessi (o disinteressi) culinari della figlia. La si mette in guardia di non "cullare" la malattia. La Harrison, per quanto di lingua inglese, sembra avere una certa cultura classico-umanistica, se avessi dovuto farle io il "rimprovero" le avrei rammentato Ulisse a casa di Circe. I compagni dell'eroe vengono trasformati in maiali. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando non esseri umani abbiamo un problema, la tendenza è quella di rotolarci nel nostro stesso fango, proprio come fanno i suini. Ci piace, è fonte del nostro male, ma al tempo stesso ci dà conforto. È una dinamica pericolosa, da cui si rischia di non uscire. E i compagni di Ulisse infatti non riescono a salvarsi, lo deve fare Ulisse per loro, qualcuno di esterno. Anche Ulisse si fa coinvolgere da Circe, ma rimane vigile, come la Harrison, e salva la situazione.
Per qualche motivo mi sono dilungato, ci tengo solo a evidenziare un ultimissimo aspetto, che genuinamente è il più sbalorditivo. I viaggi. Le due viaggiano tanto, vanno in Inghilterra (due-tre volte), in Spagna, a Roma, a Parigi. Si ha come l'impressione (sicuramente mi sbaglio, ma mi piace pensarla così) che alla fine la vera terapia sia stato viaggiare. Si è portati a pensare che, in casi come questi, non solo il malato, ma anche chi gli sta attorno, la famiglia, tendano a chiudersi in sé stessi. È normale, è la cosa intuitivamente più ovvia: già è difficile occuparsi di B. all'interno del tran-tran quotidiano, darle da mangiare, figurarsi se la si porta in vacanza, all'estero, fuori dalla sicurezza della vita di tutti i giorni. Invece no, le due viaggiano, non mi sarei mai aspettato questa parte di racconto.
Non so che intenzioni commerciali abbia la casa editrice. L'uomo marketing che è in me fa una considerazione banale: il libro è stato scritto per uno scopo preciso, quello di essere un punto di riferimento per altre persone nella stessa drammatica situazione. Evitare che, nel cuore angosciato della notte, si ritrovino a cercare su internet, dove si trova di tutto, anche cose molto fuorvianti. Ecco, mi permetto quindi di suggerire che questo libro dovrebbe essere segnalato alle strutture e ai professionisti preposti come parte del percorso terapeutico. Poi, in conclusione, segnalo altri due aspetti che mi hanno fatto sentire partecipe alla vicenda.
Uno: il libro, di fatto, è un diario, estremamente preciso anche come date. Da appassionato di storia e di date ho gradito molto. Non per spirito di erudizione ovviamente, ma perché mi ha permesso di confrontarle con vicende mie personali di quegli stessi anni. Nemmeno vicine a una situazione così drammatica, ma comunque neanche facilissime. Due: mi sono esaltato per la citazione di Virgilio all'inizio del libro. Uno dei passi più belli di tutta la letteratura latina, secondo me. Tra parentesi: una poesia che parla della notte è un notturno, come si chiama tecnicamente la descrizione di un tramonto? A parte questo, la cosa più importante: le castagne.
Ne sono molto ghiotto, ma, mi pare di capire, ne sia ghiotta anche l'autrice. Le ha molto care perché, dice, hanno nutrito i suoi antenati sull'Appennino nei secoli passati. Ma la Harrison non era scozzese? Esiste una tradizione tra scozzesi e Bagni di Lucca che risale addirittura all'Ottocento, forse è questo il caso? Al di là di ciò, il punto è che da piccolo con mia nonna andavo nel bosco a cogliere le castagne, poi tornavo a casa e le arrostivo sul fuoco, mentre giocavo a carte con lei e mio nonno cucinava. Storie di altri tempi.
BEA HARRISON, LE CASTAGNE NON FANNO PAURA diario minimo di un'anoressia mentale, IL CILIEGIO, ISBN 979-12-5610-041-5